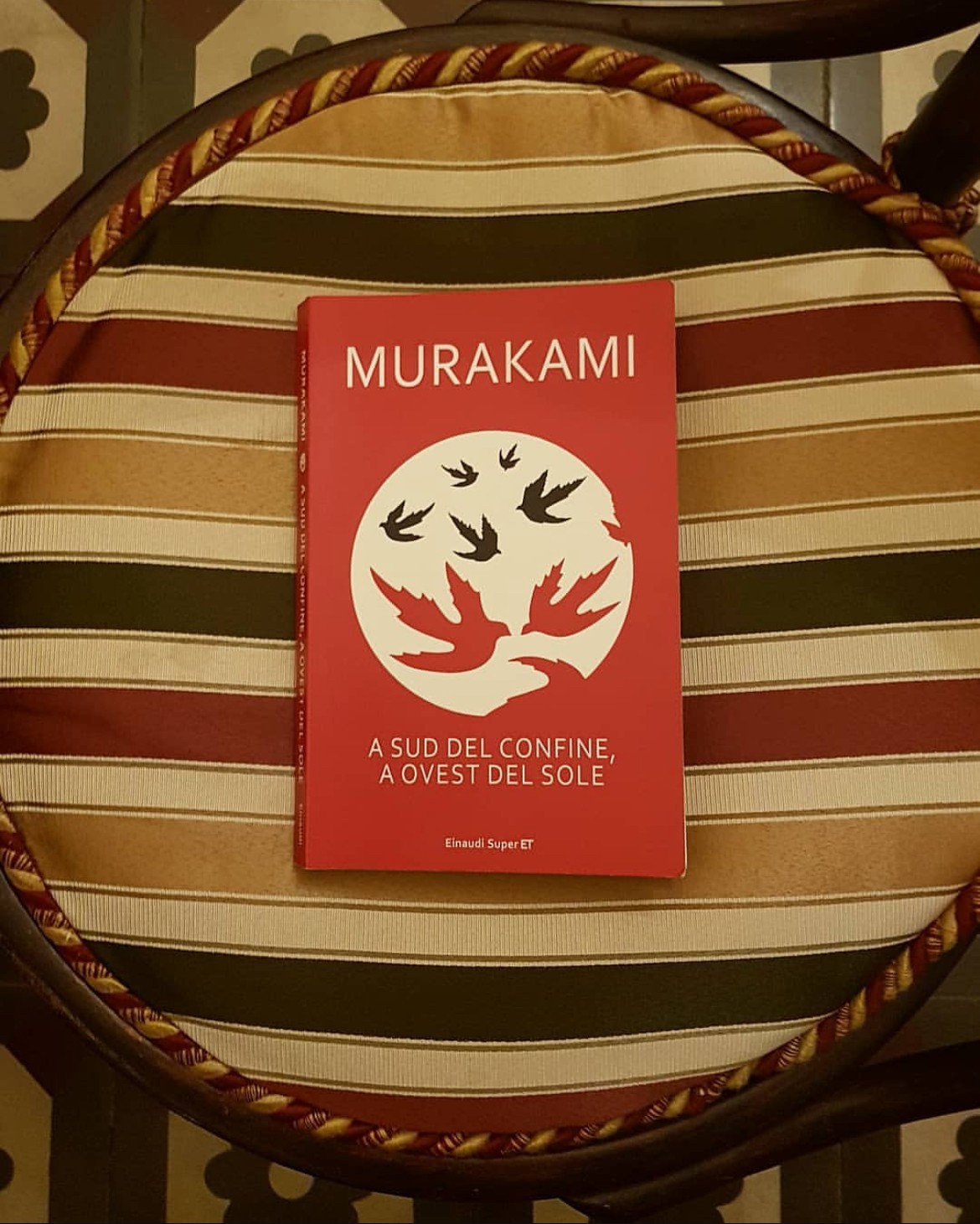Non sarai solo per sempre.
In un’ottica riduzionista abbiamo il Murakami onirico, quasi surreale e quello essenziale, intimo.
“A sud del confine, a ovest del sole” appartiene a questa seconda vena letteraria. Si configura come un incessante sguardo introspettivo-esplorativo; un romanzo che non dà risposte ma che semina, delicatamente, domande.
Hajime nasce figlio unico nel Giappone degli anni ’50. Una condizione rara per quei tempi; un’unicità che si lega inevitabilmente ad una sensazione di persistente diversità, incomprensione, solitudine. Tutto questo cambia quando, a dodici anni, sfiora la mano di Shimamoto.
“Era una sensazione mai provata prima, e mai più ritrovata. Era solo una mano piccola e calda di una ragazzina di dodici anni, ma sentivo che in quelle cinque dita e in quel palmo era racchiuso, come in una minuscola vetrinetta, tutto quello che c’era da sapere sulla vita. Prendendomi per mano mi aveva reso partecipe di quei segreti. Mi aveva fatto capire che nel mondo reale esisteva davvero un posto come quello.”
Le loro strade si separeranno, ma la donna è destinata a ritornare, stravolgendo la vita e gli equilibri dell’uomo.
Il susseguirsi lineare delle vicende e delle scelte si combina con profonda naturalezza alle “vite immaginarie mai realizzate”, a quei rimpianti che sopravvivono e che si amalgamano dolcemente alla nostra essenza.
Le persone che fanno parte della nostra vita lasciano un segno, talvolta effimero, talvolta eterno, diventando parte inestricabile dell’identità, bilancia di incertezze e decisioni future.
La solitudine che ho percepito scorrendo le pagine del romanzo è un sentimento che va oltre l’assenza dell’altro, oltre la nostalgia.
Esiste uno spazio intimo interiore che non può essere condiviso, che appartiene unicamente a noi stessi, un nucleo che ci parla e che non desideriamo ascoltare, un nucleo la cui voce può soltanto farci soffrire, ricordandoci che, in ultima istanza, siamo soli di fronte all’esistenza.